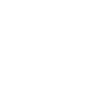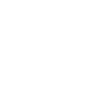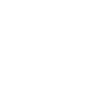Uganda: la vita è sofferenza, è precarietà, è crisi
Tororo, minuscola cittadina dell’Uganda dell’Est. Il Kenya è lì, appena dietro l’angolo. Solo le montagne separano un confine precario, fittizio, irrilevante.
Appena usciti dalla città si apre una distesa di banani, un paesaggio di un verde accecante.
Campi, alberi di mango, capanne, uomini, donne e bambini che instancabili percorrono i chilometri che li separano dal pozzo dell’acqua.
Katwe Kinyoro. Periferia sud di Kampala. I palazzi di vetro del quartiere benestante si vedono in lontananza.
I binari della ferrovia non stridono al passaggio dei treni; è una strada, un cammino incessante, un mercato all’aria aperta di ambulanti e venditori.
Uno strano odore ti entra nelle narici, arriva fin su alla testa. E’ il fabbro che lavora. Uomini che saldano. Odore pregnante di bruciato, di polvere, di inquinamento.
Nel villaggio la vita è indaffarata ma il tempo sembra non passare mai. Ognuno è al suo posto, ognuno benedice la vita per come è.
Non si pensa al passato, non si riservano sogni per il futuro. E’ il presente che conta, è in questo momento che bisogna essere felici, se si può.
La cucina ha le pareti in lamiera, sorrette da quattro bastoni. Il fuoco e la brace scaldano la pentola del riso e quella della carne.
Le donne si accovacciano per girare la zuppa. Il loro corpo, la loro schiena, disegnano nell’aria una linea perfetta, la testa sembra toccare la terra.
La casa è fatta di argilla, il tetto in paglia. Non ci sono camere, ripostigli; non ci sono mensole, non ci sono finestre.
C’è solo una porta, per entrare e per uscire. Si entra la sera per riposare, per pregare, per accudire i propri figli.
Si esce il mattino sapendo che un’altra giornata di duro lavoro ha inizio, un altro giorno uguale a quello prima, lo stesso sole, la stessa ombra, la stessa zuppa.
D. è una donna congolese, rifugiata a Kampala. Abita in Katwe Kinyoro, da soli cinque mesi.
Le chiedo perché è scappata dal Congo, queste le sue parole.
“Da noi ci sono molti problemi per i campi; siamo in una zona agricola, quindi ci sono molti problemi.
Prima ci sono dei problemi tra le famiglie, e poi ciò che aggrava la situazione è la presenza dei ribelli.
Mio marito aveva dei problemi in famiglia, e i suoi familiari sono andati a chiedere sostegno ai ribelli. L’hanno cacciato..
lui è fuggito da Rutshuru e si è rifugiato a Goma. Io sono rimasta a casa.. e un giorno i ribelli sono tornati per controllare se mio marito fosse tornato.. e mi hanno portata via da casa, nella foresta, dove mi hanno picchiata e torturata. Mi hanno colpita alla testa con una barra di ferro, violentata e poi ho perso conoscenza…
Il mattino dopo mi sono ritrovata in una fossa, in mezzo ad ossa umane e cadaveri.
Allora ho cominciato ad urlare, ad urlare, ad urlare ancora..e in quel momento mi sono accorta che avevo le gambe rotte, tutte e due, perché mi avevano picchiata.
Poi alcune persone che lavoravano nella foresta mi hanno sentita, hanno sentito la mia voce e mi hanno trovata in mezzo ai cadaveri.
Mi hanno portata all’ospedale e da lì mi hanno trasferita a Goma, dove per caso ho incontrato mio marito.
Era diventato troppo pericoloso, così appena mi sono sentita un po’ meglio siamo scappati verso l’Uganda, passando dalla frontiera di Bunagana”.
Ci sono due uomini lì dietro alla capanna che battono con un bastone la testa di una mucca appena uccisa; la coda invece viene appesa ad un ramo per essere scuoiata.
La stessa cosa con una gallina, e la stessa identica cosa per una capra.
Le pannocchie sono sul fuoco ad arrostire, il miglio nel granaio a riposare.
La birra locale fermenta dentro ampolle di argilla ed ha un sapore amaro.
E’ una birra che unisce, che fa raccontare, che fa ridere, che rende gli uomini capaci di reinventarsi, di rinascere ogni giorno.
I visi sono tirati, gli occhi socchiusi, le rughe sul volto degli uomini segnano la vita che inesorabilmente passa.
Le mani e i piedi ruvidi; sono mani e piedi che lavorano, che toccano e calpestano la natura. Le rendono omaggio, perché solo lei, la natura, può dare un senso alla vita.
A. è una donna robusta, alta. I suoi occhi sono grandi e profondi. I capelli non si vedono perché sono coperti da un foulard. Vive nel quartiere di Katwe Kinyoro da due anni.
Le lacrime cominciano a scivolare sul suo viso quando le chiedo cosa significa vivere a Kampala.
Sono lacrime amare, di un incubo alla luce del giorno. Lacrime di una donna che non sente più di essere tale.
“Quando siamo arrivati non abbiamo ricevuto nessun aiuto. Noi siamo musulmani e la moschea ci ha dato una piccola somma per affittare una piccola casa.
Da quando ho conosciuto altre donne congolesi, ho cominciato a fare delle piccole attività di vendita, di gioielli..
Ma la volta scorsa, stavo tornando dal posto dove sono andata vendere..
e ho incrociato degli uomini ugandesi..hanno cominciato a chiedermi se conoscevo delle persone, ma io ho risposto che non sapevo chi fossero.
Allora mi hanno presa, mi hanno rubato tutte le cose che avevo, la merce che avevo portato da vendere e che mi aiuta a far vivere la mia famiglia.
Mi hanno portato in un angolo un po’ nascosto.. e tutti e tre gli uomini hanno voluto fare sesso con me, per forza…
E mio marito quando ha saputo che sono stata di nuovo violentata qui, se ne è andato…mi ha abbandonata..
Ora ho cominciato a fare il bucato per le altre donne, come lavoro. Prego Dio perché custodisca la mia vita..”
Due mondi, due posti e due vite diverse.
Ma per entrambi non esistono bisogni, preferenze. Non esistono opzioni e scelte.
La vita è sofferenza, è precarietà, è crisi.
Ma si arriva a un punto in cui il niente diventa tutto, il nostro concetto di povertà diventa il loro concetto di ricchezza. In un momento forze inaudite si risvegliano e permettono di prendere respiro.
E la vita continua.