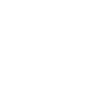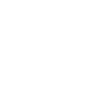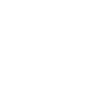La sofferenza di un rifugiato
Per arrivare ci vogliono due matatu, il primo che mi porta da Makerere alla stazione vecchia dei Taxi.
Il secondo dalla stazione vecchia dei Taxi a Nsambya Kilombe.
E’ qui che devo andare.
Questo quando è un giorno normale, quando tutto è tranquillo. Anche se poi tranquillo non è, perchè solo per raggiungere la stazione vecchia dei Taxi è un’impresa degna di una commedia o di un film d’azione, dipende dai punti di vista: chi ti saluta, chi ti ferma; qualcuno ti chiede se vuoi un passaggio, un paio di scarpe o un arancio dalla forma e dal colore improponibili. E quando finalmente, dopo mille tentativi, trovi il matatu giusto, chiedi sommessamente “va a Nsambya Kilombe?”, e il buon Sebo (signore in luganda) ti guarda storta perché l’hai pronunciato male, ti verrebbe solo da tirargli una bottiglia d’acqua in testa!!
Se invece è un giorno di scontri tra l’opposizione al governo e la polizia, e ti trovi col tuo bel matatu sfasciato in mezzo alla gente che scappa e alla polizia che carica, ti chiedi se forse non è meglio prendere un boda boda. Saranno pazzi quanto volete, ma almeno sei sicura di sgusciare via dal casino, di arrivare a destinazione in men che non si dica (ovviamente anche qui non senza difficoltà..se ha abbastanza benzina, e se non si schianta contro un’altra macchina!)
Entro in Nsambya, con i capelli tutti scompigliati e gli occhi impolverati. Chiedo al boda di fermarsi davanti alla scuola elementare e comincio a camminare in Kabega Road. E’ la via che ormai mi è più familiare.
La strada è fatta di terra rossa, quella argillosa che quando piove si attacca alle scarpe e alla pelle. Ai lati solo baracche di legno. Nient’altro. Da qualcuna di queste sbuca un bimbo tutto nudo che comincia a piangere; in altre si può comprare qualche pomodoro fresco, banane o qualche mango. Davanti ad altre ci sono uomini che parlano, che aspettano il fresco delle sette di sera, che seguono con lo sguardo il tuo passaggio.
Più o meno a metà della strada c’è un grosso campo da calcio (senza erba) e un “parco giochi” se così si può chiamare. A volte ci sono bimbi che giocano, a volte no e quando non c’è nessuno ti sembra di vedere un miraggio nel deserto. Qualcuno avrà pensato di costruirlo per rendere felici questi bambini, che però non hanno dei pantaloni intatti e una casa con il tetto.
Alla fine della strada, all’estremità opposta di quella da cui sono arrivata, ci sono tre o quattro ragazzi che rovistano nell’immondizia. C’è sempre qualcosa da cercare, ma mai qualcosa da portar via. Così decidono di star lì tutto il giorno, in attesa di qualcosa di bello o di buono.
Oltre Kabega Road c’è Kevina Road, una via affollatissima. Una baracca sopra l’altra. Sembra che ad un certo punto qualcuno abbia deciso di tagliar via dello spazio. Persone ovunque, bambini in ogni angolo, musica congolese in ogni negozio, donne che cuciono abiti, vecchi che mangiano, altri che urlano. Umanità, come si dice. Si dice anche dalle nostre parti, ma non se ne comprende il significato.
Bella umanità, ma che fa pensare. Arriccia le tue certezze e butta al vento le tue categorie eurocentriste.
I rifugiati vivono in città-slum, subito fuori dal centro, e quasi sempre tendono a raggrupparsi per nazionalità:
62% congolesi
35,22% somali
2,6% burundesi
Questi i numeri dei soli rifugiati urbani in Kampala nel 2012.
La Nsambya di cui vi ho parlato si trova in Makindye Division, area urbana all’interno di Kampala con la più alta concentrazione di rifugiati congolesi. La comunità congolese è presente anche in Katwe e in Masajja. I rifugiati somali si concentrano invece in Kisenyi.
Le condizioni di vita sono squallide.
Arrivano dalle aree rurali, dove sono presenti settlements agricoli (una soluzione teoricamente temporanea, ma in pratica durevole per un’intera vita). Arrivano direttamente dal loro paese d’origine. Oppure attraverso stati di transito come il Kenya.
Vengono classificati in vulnerable households (famiglie vulnerabili) e struggling households (letteralmente famiglie che lottano).
Cioè quello che cambia è la quantità e la qualità della sofferenza. Ma sempre di sofferenza e di lotta si tratta. Perennemente in bilico tra il passato e il presente, tra la terra d’origine e quella di arrivo, tra un nome proprio acquisito per via sanguigna, e un nome legale, un nome proforma, una categoria che etichetta e che plasma la quotidianità. Rifugiato.
Restiamo umani.