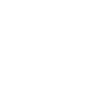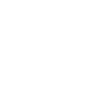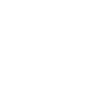Corpi in movimento
Nakivale è un posto fuori dal mondo e da ogni immaginazione.
Non è Uganda, non è Africa e men che meno Europa. Anche se tutto, dalla forma al contenuto, è figlio dell’Occidente.
Nakivale è il settlement più grande e più vecchio dell’Uganda. Aperto nel 1950, oggi ospita circa settanta mila rifugiati.
Il paesaggio si trasforma, niente più case, nessun negozio, nessun benzinaio. L’asfalto diventa improvvisamente polvere rossa, gli alberi verdi in arbusti gialli e secchi.
Se sapessi come è fatto Marte, vi direi di esserci stata. Se sapessi come è fatta l’isola più sperduta nell’oceano più lontano del mondo, vi racconterei di averci vissuto.
Ma al di là di parole retoriche, Nakivale si stende in una delle aree più remote dell’Uganda, al confine con la Tanzania e il Ruanda, dove l’acqua e l’umanità sembrano farsi più rari.
Dire settlement non è dire campo. Dietro la parola “campo” dovrebbe esserci l’idea di provvisorietà, di transizione, di una soluzione temporanea. Dietro quella di “settlement” l’idea di permanenza, di stabilità, di una soluzione durevole.
Ma in entrambi c’è qualcosa che eccede. E l’eccedenza sono le persone che ci vivono: individui, in ogni caso, “fuori posto”.
A ogni passo le aspettative si sgretolano. Se pensavi di entrare in una specie di prigione dove le persone non possono fare altro che aspettare; se immaginavi di vedere case ammassate o container identici, uno dopo l’altro, disposti in un ordine compulsivo e totalitario; se ti aspettavi di conoscere delle persone sofferenti sotto tendoni bianchi e blu dell’UNHCR: allora scopri che gli stereotipi modellano la tua vita, a loro piacimento. Un’immagine del rifugiato che solo noi sappiamo costruire, noi con le nostre leggi, la nostra pietà e la morale del mondo moderno.
A ogni passo le contraddizioni vengono a galla. Ciascuno costruisce la propria casa con il materiale che trova. Case di terracotta spuntano qui e là in mezzo alla vegetazione, per chilometri e chilometri. Basta pagare di nascosto il comandante del campo per farsi dare il terreno più bello. Ciascuna famiglia ha il diritto ad un pezzo di terra da coltivare, ma in realtà non tutti lo posseggono. Pomodori, patate, manioca e cipolle dovrebbero essere sufficienti per sfamare chi possiede la terra, ma il sole distrugge qualsiasi cosa, per cinque o sei mesi all’anno. Si dice che essere rifugiato nel settlement significhi essere autosufficiente, perché secondo un ragionamento degno della logica occidentale, più stai in un posto più saprai come cavartela con il passare del tempo. Ma poi ti ritrovi con 6 kg di mais al mese del WFP (World Food Program), la scuola gratis ma scadente dell’UN, i servizi medici finanziati dal governo giapponese.
Così, come in qualsiasi altro contesto, si finisce per essere dipendenti dall’assistenza. Una dipendenza che certo non è scomoda, ma che ti riduce ad essere un subordinato, un individuo che non è mai finito nella sua persona e nei suoi diritti. Non c’è parità e soprattutto un reciproco scambio. Il rifugiato sarà sempre colui che riceve, mai colui che darà.
Ma in ogni caso rifugiati non si nasce, si diventa; e ciascuno di loro decide come esserlo e come impersonare questa etichetta.
I somali e gli etiopi sono quelli del business e del commercio. Sono quelli che riescono a mantenere i legami con i propri parenti e amici rimasti in patria. Ricevono soldi e li fanno fruttare. Hanno persino una banca interna al campo. Giorno dopo giorno la loro origine, la loro storia e la loro cultura si riproducono nelle strade del settlement. Le vie somale sono colorate, immerse nel profumo di spezie; ci sono ristoranti e negozietti. Gruppi di uomini si riuniscono attorno ad una radio per sentire le ultime notizie oltre frontiera. Le donne chiacchierano davanti casa, i bambini sfoggiano le loro biciclette nuove.
I ruandesi e i burundesi sono quelli che lavorano nei campi, che coltivano e allevano animali. Hanno una grande energia e un grande amore per la terra. Sono quelli che lottano per rimanere, per non essere rimpatriati. Potrebbero tornare nel loro paese, ma non saprebbero dove. Terre e case sono ormai altrui.
I congolesi sono quelli che più risentono della guerra. Sono quelli che rimangono a casa tutto il giorno, che dicono di essere stanchi ed esausti per poter coltivare. Sono quelli che non sanno come uscire dai propri ricordi, come cancellarli. Perché il passato è ancora presente, è recente nelle ferite, nelle parole e nelle persone che ancora oggi scappano e che arrivano nel campo. Per loro la violenza c’è ancora, così come la discriminazione e e i conflitti inter-etnici.
Christopher arriva da Uvira (provincia del Sud Kivu, Repubblica Democratica del Congo). La sua tribù è quella dei Banyamulenge, gruppo minoritario di Tutsi, “senza stato” e da sempre marginalizzato a causa di complessi conflitti storici e fattori politici all’interno e fuori dal Congo. Nel 1998 Christopher si trova in mezzo alla guerra tra i ribelli May May e Interahamwe. Suo padre, le sue sorelle e tre fratelli sono stati chiusi in casa dai ribelli e bruciati vivi. Ancora oggi non sa se sua madre e un fratello siano vivi o morti.
Fugge da solo, passando da Bukavu, da Goma e poi da Bunagana, fino ad arrivare nel settlement nel 2001. A quel tempo aveva 19 anni. All’inizio la vita nel campo non era facile per lui così giovane, per cui decide di spostarsi e di vivere in un paese vicino, ma la gente del posto comincia a perseguitarlo, perché Banyamulenge. Dal 2002 al 2009 vive in una chiesa, ma non senza difficoltà; si sente comunque minacciato e considerato “straniero”; comunque rifugiato, senza terra e documenti. Così nel 2009 decide di tornare nel settlement e di costruirsi la sua casa.
Oggi ha 32 anni, è solo, con la sua terra e le sue preghiere.
E’ così che si vive, senza sapere quanto tempo si starà ma senza desiderare un ritorno. Piccoli stati e grandi rancori si riproducono a macchia d’olio, come se si fosse destinati a vivere sempre gli stessi dolori in qualsiasi parte del mondo. Ci si pensa liberi, ma in realtà si è imprigionati nella morsa umanitaria e del dominio, senza un punto di ritorno né una via di uscita. Questa la grande sconfitta dell’Occidente, dal colonialismo al campo.
Quei corpi insicuri che vogliamo proteggere, quei corpi malati che vogliamo curare dalle nostre stesse ferite, in realtà sono corpi in azione. Si fa quel che si può per dare dignità ad un pezzo di pane, ad una lezione di inglese e ad una tanica d’acqua.
Corpi in movimento, per mettere da parte i giorni andati.
“Quando penso al Congo, so che morirò il giorno stesso a causa della guerra, quando penso alla vita qui, so che morirò il giorno dopo per la fame. Quindi è meglio stare qui e vivere un giorno in più.”
(Claudine Birori, Congo)
L’esperienza di Miriam
LA TERRA E’ UNA QUESTIONE SERIA