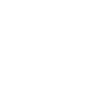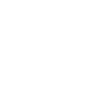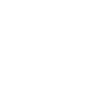Luciano Gallino, pensatore libero
Luciano Gallino ci ha lasciati domenica 8 novembre. Un pensatore libero, che ha dato tanto alla riflessione su economia, potere, mercato del lavoro.
La sua strada è partita da Ivrea, insieme ad Adriano Olivetti, e a cominciare da quell’esperienza ha viaggiato in tutto il mondo, ricercando e insegnando sociologia.
In questi anni l’abbiamo incrociato tante volte e spesso le sue parole sono state di riferimento, sempre puntuali.
Riportiamo l’intervista pubblicata nel 2006 nel libro ‘Voci da una Torino che cambia’, dove avevamo dialogato di Torino e di economia post-industriale. E’ ancora attuale in tema di diseguaglianze e redistribuzione del reddito, con una capacità di guardare al globale senza perdere di vista il locale.
Ciao Professore!
GUARDARE AL DI LÀ DI TORINO
di Luciano Gallino
Quanto sono centrali i trust di potere economico-finanziario e come si potrebbe riportarli sotto un controllo democratico, legato a un certo territorio?
Sul piano mondiale, riportare in blocco quei poteri sotto una qualche forma di controllo credo sia un’impresa disperata, perché nel tempo hanno accumulato così tanti capitali che i più grandi investitori muovono portafogli dell’entità di oltre 30.000 miliardi di dollari, cioè poco meno del PIL mondiale. In altre parole hanno un portafoglio che equivale circa al PIL del mondo in un anno, e lo possono spostare da un’impresa a un’altra con estrema facilità, a colpi di click o con una telefonata. Questi poteri sono difficilmente controllabili in blocco, ma ci sono delle strade alternative percorribili. Si tratta di soluzioni minori, ma che comunque possono dare qualche risultato.
Credo, per esempio, che andrebbe ripensato e ristrutturato il processo tra economie regionali ed economie
globali, perché bisognerebbe distinguere (e questo la politica potrebbe/dovrebbe farlo) che cosa conviene produrre in un ambito regionale e cosa invece è bene venga prodotto su scala mondiale, per la convenienza sia del Paese che produce, sia di chi acquista. Si parla in termini di convenienza dei prezzi e di vantaggi comparati. Oggi l’economia globalizzata ha delle componenti grottesche, perché finisce col distruggere l’economia locale e regionale, con il gravissimo rischio che, qualora ci siano momenti di crisi da
altre parti, l’economia locale non riesca a far fronte ai problemi e ai bisogni. Questo dovrebbe essere un fatto trattato dalla politica sia a livello territoriale sia su vaste aree, anche a livello dell’Unione Europea. L’Unione Europea è essa stessa un “fortino neoliberale” e l’attuale Commissione è la più neoliberale che ci sia mai stata. Questo tentativo di ridefinire i confini tra locale e globale potrebbe sicuramente essere tradotto in un progetto politico. Vi sono poi altri aspetti su cui la politica può incidere; uno dei prodotti drammatici della globalizzazione sono le forti disuguaglianze, che si sono generate sia a livello internazionale sia a livello nazionale.
L’Italia è un Paese sempre più diseguale, ma lo sono anche la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti; per non parlare delle disuguaglianze a livello mondiale, su cui è stata richiamata l’attenzione con l’ultimo rapporto sullo sviluppo umano promosso dalle Nazioni Unite. I dati sono pesanti e sottolineano forti diversità, soprattutto riguardo all’aspettativa di vita, alla mortalità infantile, ecc.
La distribuzione delle risorse è un’attività da sempre esercitata dalla politica, che potrebbe essere rivalutata con un’adeguata politica fiscale e una nuova regolamentazione dello stato sociale. Il taglio alle pensioni, il taglio al TFR, che stanno passando quasi come se nulla fosse, sono in realtà interventi aggressivi in ambito distributivo, perché tutto ciò passa dall’essere finanziato dal contributo collettivo all’essere finanziato dal singolo individuo: e incaricare il singolo di finanziare integralmente la propria pensione è equivalente ad aumentargli le tasse del 30%. E questo mentre le tasse sono diminuite per chi guadagna milioni di euro.
La redistribuzione delle risorse economiche a livello nazionale e internazionale è un compito che spetta alla politica e che la politica dovrebbe riassumere in pieno, dandosi strumenti adatti ai tempi.
Veniamo a Torino: cosa c’è alla base dello sviluppo di Torino, di questo modo di intendere il futuro di Torino, che era nel Primo Piano Strategico e che è nel Secondo Piano Strategico in discussione?
Sicuramente ha pesato, ma non soltanto per quella parte neoliberale che riguarda la deregolazione e l’uscita dal pubblico in favore del privato, ma anche per la componente ideologica, cioè l’idea che si possa tranquillamente procedere a forme di deindustrializzazione avanzata e si possa completamente trasformare la città nel senso postindustriale. Mi pare però che negli ultimi due o tre anni ci siano stati vari ripensamenti da questo punto di vista. Tempo fa molti dicevano, o lasciavano intendere: «Se anche la FIAT scompare, chi se ne importa, noi avremmo il turismo, le Olimpiadi, le economie della conoscenza», anche se, a scendere nel particolare, queste economie della conoscenza nessuno sa bene cosa siano. Mi pare invece che oggi si sia più cauti, ci sia maggiore attenzione ai problemi che riguardano l’industria. Ha però pesato molto il fatto che per anni si sia pensato che demolire l’impianto industriale di Torino e del Piemonte, in fondo, non avesse molta importanza. Si veda, ad esempio, cos’è successo a Ivrea. Ivrea e il Canavese ora sono il “deserto” e qualcuno ha chiamato quanto si è verificato in queste zone – senza usare un’espressione troppo fuori luogo – un
omicidio industriale: li c’erano fabbriche con 25.000 operai; adesso ci sono un po’ di call center e tante piccole fabbriche, che stentano terribilmente a diventare tessuto, a diventare distretto. Torino dovrebbe guardare un po’ di più a cos’è successo nel Canavese, dove era stato teorizzato che in fondo produrre beni o servizi tangibili non importava più e che si poteva andare verso una qualche fonte economica di conoscenza. C’è sicuramente stata una corrente neoliberale anche nelle forze di centro-sinistra, ma molti problemi sono stati il risultato di una scarsa cultura su ciò che significa industria, su quali possano essere le sue effettive trasformazioni.
La “Torino della conoscenza”, questa Torino postindustriale che rinuncia di fatto alla manifattura, come potrà occupare le tante persone che oggi abitano in città, rinunciando all’industria e alla produzione di beni tangibili?
Naturalmente bisogna guardare un po’ anche al di là di Torino, perché in Piemonte esiste ancora un grosso “pezzo” di industria, che è fatto di tanti pezzi, come ad esempio il sistema della fornitura dell’auto, che oggi lavora al 60% per l’estero, per gli stessi concorrenti della Fiat come la Volkswagen, la Crysler, la Ford o altri.
Oggi l’auto è fatta per due terzi al di fuori di quello che è il committente principale e gli studi disponibili dicono che si andrà verso il 75% e oltre. Questo vuol dire che per 15.000 in Fiat ce ne saranno probabilmente 60.000 o più al di fuori, che lavorano solo per la Fiat: e se in Piemonte ci si muove bene, una parte importante della componentistica europea può continuare a passare per la nostra regione. Rispetto ad altri Paesi, come la Francia o la Germania, c’è una notevole miopia perché si ragiona sulla Fiat e non sulla semplice fabbrica dell’auto che è racchiusa entro un perimetro maggiore, che attraversa gran parte del Piemonte. Qui si inseriscono degli altri problemi, perché una parte rilevante delle componenti Fiat, in realtà, arriva dal centro-sud, tanto è vero che se si fermano gli stabilimenti a Melfi, si ferma anche Mirafiori. Questo non è un buon segno, dato che in Europa la tendenza è ad avere sempre più distretti in prossimità, soprattutto per le parti più grosse e ingombranti, mentre la Fiat fa viaggiare proprio queste parti per 900 chilometri.
Magari sarebbe conveniente fare l’assemblaggio là piuttosto che in Piemonte. Il contrappeso è che la componentistica piemontese lavora per mezzo mondo, se non due terzi di mondo, quindi bisogna ragionare sul complesso del settore industriale, come fanno tedeschi e francesi. Poi ci sono altri pezzi dell’industria.
Insomma c’è più di quanto non si veda guardando soltanto i cancelli di Mirafiori.
Chi in questi due anni e mezzo ha contribuito a rilanciare il tema dell’industria manifatturiera da tenere in Piemonte?
Su questo non vi è dubbio: soprattutto i sindacati. I sindacati hanno infatti una conoscenza diretta, molto definita e precisa. Hanno posto alla città il problema di cosa voglia dire deindustrializzazione: in primo luogo, molti posti di lavoro in meno.
Parliamo del concetto di soft landing. In questo “atterrare dolcemente” si sta immaginando un deflusso dalla città. Lei cosa pensa di tutto questo, soprattutto riguardo all’impatto sociale che questo fenomeno ha e avrà?
Per prima cosa vorrei che questo soft landing fosse definito con un po’ più di chiarezza e anche con un po’ più di competenze tecnologiche, industriali ed economiche. Perché si parla di economia della conoscenza ma alla fine ci sono pochi tipi di conoscenza che possono produrre posti di lavoro: i due tipi di conoscenze che producono lavoro sono infatti i servizi finanziari e i servizi collegati alle imprese. Gran parte dell’informatica, della produzione di software, compresa la produzione fisica di computer, nasce dalla domanda di servizi alle imprese. Anche le persone singole chiedono servizi informatici, ma ciò che produce reddito sono i servizi finanziari e i servizi alle imprese, prevalentemente del settore industriale. In Europa, i servizi finanziari vengono forniti soprattutto dal Gran Bretagna: la più grande piazza finanziaria europea è Londra, dove ci sono centinaia di migliaia di addetti molto qualificati. È impensabile che i servizi finanziari si sviluppino a Torino; perfino Parigi e Francoforte sono declassate in questo campo. Un conto infatti è avere delle banche, un conto è fornire servizi finanziari come fanno gli inglesi. L’altra parte di servizi collegata all’economia della conoscenza è legata all’impresa: è cioè il sistema nervoso che tiene insieme la logistica, i tempi, la fornitura, la gestione del personale e mille altre atti-vità del genere. Quindi se non c’è industria non ci possono essere i servizi, né la città della conoscenza. Tutti i settori che si collegano all’economia della conoscenza, e che a Torino comunque non sono ancora sufficientemente sviluppati, hanno uno stretto legame
con il settore industriale. Ad esempio, nel campo delle biotecnologie si fa una grande applicazione di conoscenza e lavoro al microscopio, decodificazione, ecc. Poi però tutto finisce in laboratorio, dove si producono molecole, tecnologie ottiche, nuovi materiali, nanotecnologie: è tutta industria, ma con elevatissimi contenuti di conoscenza.
Quindi se si considera in profondo che cosa voglia dire conoscenza applicata all’industria o conoscenza applicata ai sistemi finanziari, resta qualcosa da spiegare: i servizi finanziari non li possiamo fare, comunque non al livello londinese; e se poi l’industria non funziona più, allora chi alimenta la domanda di servizi informatici e di conoscenza in generale?
Ho quindi molti dubbi che esistano degli spazi sufficienti per impiegare decine di migliaia di persone.
In Piemonte poi ci sono altre realtà importanti: il tessile adesso è in crisi, ma potrebbe anche riprendersi; vi sono centinaia di manifatture di nicchia, che occupano migliaia di persone, da Settimo a Verbania. A Settimo, per esempio, si fanno metà delle penne del mondo e così lavorano molte migliaia di persone.
Nei decenni passati si è venuti a Torino partendo dalla Calabria e dalla Puglia, più recentemente, dalla Romania e dal Marocco: è uno scenario plausibile o è fantascienza immaginare, negli anni futuri, i ragazzi di cui dicevamo prima che fanno la valigia e vanno a cercare lavoro a Pechino piuttosto che a Hong Kong?
Se si accontentassero di guadagnare 100 o 200 euro al mese sarebbe realistico, diversamente non lo è affatto: questi purtroppo sono i divari delle retribuzioni; addirittura, se uno riuscisse a inserirsi nell’élite di Pechino o di Canton magari potrebbe arrivare a guadagnare 700 euro al mese, altrimenti le retribuzioni sono di gran lunga inferiori. Le grandi commesse di software europee vanno in India perché gli ingegneri indiani, che sono bravissimi, guadagnano un quinto o anche meno degli ingegneri americani ed europei.
Adesso si va anche in Polonia, in Estonia o in Bulgaria, dove non sono bravissimi ma guadagnano il 20-25 % di quanto si guadagni qui. Se emigrazione vuol dire andare là, qualche imprenditore lo ha già proposto: io non delocalizzo, non vado in Moldova, se voi vi accontentate degli stipendi moldovi o poco più, ossia 100 euro al mese. Probabilmente faceva dell’ironia, ma insomma, questo è il punto.
Quanto al ritorno al Mezzogiorno, è stata pubblicata l’indagine sulla povertà e risulta che nelle regioni meridionali circa il 25% delle famiglie è povera, in Sicilia si arriva al 30%. Tornare dal Piemonte in quelle regioni con flussi inversi mi pare fantascienza.
Si pensa che si stiano erodendo i risparmi delle precedenti generazioni, per vivere in un momento di crisi, senza variare il livello di consumo.
Non ci sono solo i risparmi delle precedenti generazioni. C’è anche il paracadute delle Olimpiadi, della metropolitana e del passante ferroviario, che complessivamente rappresentano molte migliaia di posti di lavoro che in parte continueranno ancora per parecchi anni.
Credo che questo argomento abbia dei fondamenti ragionevoli; è un argomento a favore della trasformazione della base industriale, ma non della sua liquidazione. Però, ripeto, bisogna guardare a questi grandi perimetri e bisogna fare i conti con il complesso dell’industria piemontese, che non è solo Mirafiori. Vi sono distretti importanti, come il tessile, in cui sono occupate decine di migliaia di persone, e sono complessi su cui occorre ragionare.
Secondo lei in questo momento, in Piemonte, c’è la capacità da parte dei decisori politici (intesi a 360 gradi, quindi non solo quelli istituzionali ma anche le banche, le associazioni di categoria, ecc.) di avere una visione d’insieme su una strategia complessiva per il Piemonte?
La capacità si vede dalle decisioni che vengono prese: e negli anni scorsi sicuramente non se n’è vista molta. Si può sperare che funzioni un po’ meglio nel prossimo periodo. Mi pare ci sia un po’ più di solidità rispetto a qualche anno fa, più di quanta si potesse sperare per come sembrava all’inizio. Sicuramente la situazione è, e rimane, critica, ma ci sono anche dei punti di forza, perché delle fabbriche ci sono ancora, molte lavorano per conto loro, si sviluppano. Occorrerebbe però allargare il dibattito all’insieme dell’industria piemontese, smettendo di guardare solo a Mirafiori, perché così facendo sfuggono tre quarti dell’industria. I discorsi che si fanno a Torino spesso sono un po’ troppo legati alla cinta daziaria, mentre bisognerebbe andare un po’ più in là, perché si può anche pensare ad uno spostamento tra immigrazioni e passaggi da un settore all’altro, così che si vada da Torino al Canavese e viceversa.
Questa appare certamente una soluzione più realistica che non pensare a Pechino, o anche solo a Crotone o a Gela.