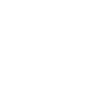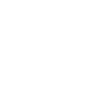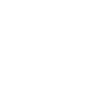Il ruolo dei docenti
Il terzo incontro della Scuola di Quartiere affronta la questione della Comunità Educante con una delle componenti fondamentali della scuola: i docenti.
L’espressione “comunità educante”, oggi sempre più diffusa, se da una parte è suggestiva e affascinante, dall’altra è controversa e soggetta a possibili fraintendimenti. Lo dimostrano le diverse voci dei protagonisti della Scuola di Quartiere: docenti desiderosi di cambiare la scuola, ma che nella comunità educante vedono sia potenzialità che pericoli.
Comunità evoca l’aspetto relazionale tra docenti e studenti, nell’idea che le due componenti condividano non solo spazi e tempi, ma anche finalità e obiettivi. Dietro la volontà di consolidare la comunità scolastica vi è la convinzione che un reale apprendimento sia possibile solo se si è creata una reale relazione fra insegnante e studente, in grado di dare senso alle nozioni e alle competenze trasmesse dalle lezioni.
D’altra parte, tuttavia, l’espressione “comunità” può richiamare anche altri significati: un’idea di omologazione e di confusione di ruoli che secondo alcuni potrebbe nuocere al ruolo e al compito della scuola pubblica.
Educante è un aggettivo a sua volta controverso. La funzione della scuola è quella di educare? Se sì, a cosa? Secondo quali valori? Anche su questo aspetto le opinioni sono molteplici. Secondo alcuni la scuola dovrebbe provocatoriamente essere una comunità “dis-educante”: se, come sosteneva Don Milani, “l’obbedienza non è più una virtù”, la scuola, nell’accompagnare la crescita degli studenti, dovrebbe insegnare loro a costruire un pensiero critico sulla realtà in una prospettiva anche politica.
In tale cornice si inserisce la questione della valutazione: che cosa esprime? Qual è il suo ruolo nello stimolare l’apprendimento degli studenti? La valutazione numerica è l’unica possibile?
Come emerge dall’eterogeneità degli interventi, è necessario costruire un vocabolario condiviso dagli attori della scuola, per poter riempire di significato quella che rischia ancora di essere un’espressione vuota.
“E’ possibile una comunità educante?” – Cristina Zeni
Parto dal dire che con questo mio intervento cercherò di rispondere affermativamente alla domanda “E’ possibile una comunità educante?” piuttosto che “Esiste la comunità educante?”. In quest’ultimo caso, infatti, la risposta presupporrebbe l’individuazione di una realtà di comunità che sia già in grado di educare a 360 gradi, con tutti i “connotati a posto”. Mi sembra invece più interessante provare ad individuare alcuni criteri e ipotizzare delle direttrici che possano portare una comunità a migliorare in tal senso. La continua ricerca è la migliore strada per arrivare alla meta. E ricerca con tensione solo chi si riconosce in qualche modo imperfetto.
Nel pensare a cosa dire, mi è sembrato opportuno partire dalle “parole”. Esse sono il “materiale grezzo” con cui comunichiamo, ma spesso e volentieri trasmettono significati differenti in base a chi le pronuncia o a chi le recepisce. E questo fatto non aiuta la comprensione reciproca. Anzi, penso sia uno dei fattori principali che impedisce a un insieme di persone, una comunità, di costruire e di andare nella stessa direzione.
Per “comunità” si intende appunto un “insieme di persone che vivono sullo stesso territorio o che hanno origini, tradizioni, idee, interessi comuni” (Dizionario Garzanti). Si capisce perché in un mondo sempre più multiculturale, variegato e complesso come quello contemporaneo non sia immediato o scontato “fare comunità”. Le origini, le tradizioni, le idee sono molte e diverse. Occorre quindi concentrarsi sugli interessi, cioè sugli obiettivi, sui fini.
Nel nostro caso, la comunità “educante” ha, per sua definizione, lo scopo di “educare”. Ma cosa vuol dire “educare”? Tutti sanno l’etimologia della parola “educĕre”: “condurre fuori”, aiutare a far emergere ciò che già è insito nella persona che io, educatore, ho davanti. Aiutare, quindi, a scoprire, a tirar fuori talenti, potenzialità, abilità ecc, ma anche comprensione di sé (atteggiamenti ma anche attitudini), tutto ciò, insomma, che consente all’individuo di comprendersi e, quindi, di crescere.
Chiarire lo scopo dell’educazione, a mio avviso, aiuta le persone coinvolte nel processo educativo a concepirsi come comunità e a tendere, compatibilmente con le peculiarità di ciascuno, verso la stessa meta.
Condividere l’obiettivo, come su una barca a vela che deve prendere il largo, favorisce la possibilità che l’equipaggio della “comunità educante” innanzitutto salpi dal porto e poi proceda verso l’orizzonte.
L’orizzonte. La meta. Per educare, per collaborare nella scoperta della realtà e di se stessi di un giovane è fondamentale dare una prospettiva, una visione ampia. Non si impara Leopardi se in qualche modo non lo inserisco in un contesto di senso più ampio. Diceva Saint-Exupery: “Se vuoi costruire una barca – tanto per rimanere nella metafora -, non radunare uomini per radunare legna, dividere i compiti e impartire legna, ma insegna loro la nostalgia del mare vasto e infinito”.
Chi è mai stato in Portogallo a Cabo de Roca capisce quanto sia vera questa frase: sul promontorio a picco sull’Oceano Atlantico, il luogo più a occidente del continente europeo, si comprende come i nostri antenati abbiano deciso e tentato con tutti i mezzi di avventurarsi in mare verso mete sconfinate. Non si può che desiderare di andare!
Per educare, per tirar fuori il meglio dell’altro occorre dare orizzonti.
Non basta dire: “La scuola serve per costruirti un futuro” oppure “La scuola serve per diventare buoni cittadini”. Tutti questi obiettivi sono assolutamente insufficienti per smuovere l’interesse in un giovane. La scuola ha bisogno di trasmettere la passione del conoscere, la curiosità dei perché delle cose, il rispetto per se stessi e per gli altri. Non si costruisce nessun futuro senza passione, né si è buoni cittadini fino a quando non riconosco nell’atro un punto in comune con me. In secondo luogo, in una comunità educante è fondamentale la relazione: se non c’è connessione, dialogo, non c’è incontro. Relazione vuole dire legame. E il legame implica fatica, tempo, spazio, sacrificio, ascolto.
Mettersi in ascolto di chi ho davanti, sia per lo studente che per il docente, è una decisione che va presa per stima. La relazione diventa autentica, cioè porta a un risultato di comprensione reciproca, se c’è stima, se chi è educato vede nell’educatore qualcosa di interessante per sé, ma anche se l’educatore trova una soddisfazione nel comunicare se stesso insegnando. Quando questa stima si instaura allora c’è relazione.
Allora c’è la possibilità che il messaggio educativo, sia esso una conoscenza meramente disciplinare sia esso un atteggiamento di fronte alle cose, passi, si comunichi, si trasmetta.
A questo punto però occorre tornare al punto di partenza. “Educare”, abbiamo detto vuol dire “tirar fuori”.
L’educatore, sia esso genitore o insegnante, ha il grande e difficilissimo compito di fare, a un certo punto, un passo indietro. Il suo scopo non è quello di inoculare la concezione migliore dell’esistenza nell’altro, fosse anche la visione delle cose più saggia e buona di questa terra, ma ha l’arduo dovere – arduo proprio dal punto di vista dell’educatore – di consegnare una proposta educativa e di fornire un metodo ragionevole per vagliarlo. E’ il giovane, durante il suo cammino di crescita, e in particolare al termine di esso, che dovrà valutare quanto sia valido ciò che gli è stato proposto, dalla ricchezza della tradizione culturale insegnata a
scuola ma anche dai modi di essere e di vedere dei suoi insegnanti o genitori.
L’immagine più semplice per capire questo è quella che si rifà alle bisacce di esopica memoria: ogni ragazzo ha una bisaccia sulle spalle che man mano che cresce gli viene riempita prima solo dai genitori, poi da amici
e conoscenti, e in particolare dagli insegnanti. Ad un certo punto questa bisaccia dovrà essere spostata davanti agli occhi del giovane che ci guarderà dentro e vaglierà quello che contiene. Se non ha imparato un metodo per vagliare in modo critico e personale, difficilmente sarà libero da condizionamenti
Per concludere, direi che una comunità è possibile se esiste uno scopo riconosciuto e condiviso. Ed è possibile che questa comunità educhi se si fonda sulla relazione, la fiducia e il dialogo. Tendere a questo nel quotidiano vuol dire tanta creatività: vuol dire accettare di ascoltare chi ha qualcosa da dire, vuol dire sanzionare i comportamenti negativi ma mai stigmatizzarli, vuol dire puntare sul fascino che la nostra cultura possiede per entrare in dialogo con la modernità.
“Costruiamo con fiducia” – Paolo Giacotto
Svolgerò alcune brevi considerazioni sul tema della costruzione della fiducia a partire da una
questione specifica: il momento della valutazione (in particolare nel rapporto allievi-insegnanti, tralasciando quanto si potrebbe dire sulla stessa questione relativamente al rapporto interno tra i docenti e tra i docenti e le famiglie).
Parto da una premessa generale.
Alcuni studiosi della comunicazione interpersonale sostengono che la valutazione è implicita in ogni relazione e che in ogni atto comunicativo c’è sotteso un messaggio che rivolgiamo all’interlocutore, che può essere reso con l’espressione “ecco come io mi vedo”, accompagnato da una domanda implicita (“e tu come mi vedi?”): ci aspettiamo dall’interlocutore un segnale di risposta.
Tre sono i possibili tipi di risposta: la conferma, “anch’io ti vedo come tu ti vedi”, il rifiuto, “no, non ti vedo come tu ti vedi”, la disconferma, “tu per me non esisti”.
Se riportiamo questi tre tipi di risposta al rapporto tra docente ed allievo/a, la risposta di conferma, “sì, anch’io ti vedo come tu ti vedi” ha un effetto di rinforzo, di consolidamento della consapevolezza di sé, dell’autostima dell’allievo/a; la risposta di secondo tipo “no, io non ti vedo come tu ti vedi” può avere due effetti molto diversi: uno doloroso , se non viene fatto con cura e attenzione da parte dell’insegnante; uno costruttivo, qualora rifiuti un’immagine negativa che l’allievo/a ha di sé (“in matematica sono negato”).
La terza risposta “tu per me non esisti” è quella più distruttiva per l’allievo/a: l’insegnante pensa che l’allievo sia del tutto inadatto, non abbia nessuna capacità, e non si rapporta in alcun modo a lui/lei; ma ci può essere anche un’altra forma di disconoscimento.
L’insegnante Guido Armellini ha raccontato di un allievo disabile che, non si sa per quale motivo, era stato iscritto dalla famiglia ad un istituto professionale per orologiai. Nonostante fosse inadatto il consiglio di classe, forse per un malinteso senso di compassione, ogni anno lo promuoveva, producendosi in una non-valutazione delle sue prestazioni. Anche questo è un modo per non vedere l’allievo per quello che egli è. Armellini conclude osservando che «non “vedendolo” come essere umano concreto e individuato, gli insegnanti finivano per imprigionarlo dentro la categoria astratta “handicappato”» 1 .
Ho fatto questa considerazione di ordine generale per dire che la valutazione è implicita in qualunque relazione e a maggior ragione nel rapporto tra docente ed allievi e che quindi gli insegnanti dovrebbero avere piena consapevolezza della “presenza” di questo aspetto nei loro rapporti con gli allievi; questa consapevolezza è una delle condizioni per creare un clima di fiducia all’interno della classe.
Venendo alla questione della valutazione scolastica in senso stretto, nei documenti internazionali Ocse o della Ue il termine valutazione è reso con l’inglese assessment.
Tale termine viene dal latino assideo, assidere e due sono i suoi significati più ricorrenti: 1) “sedersi accanto, stare accanto”; 2) “assediare”. Nella prima accezione la valutazione assume la forma di un’attività di assistenza e collaborazione, nella seconda richiama l’idea di una contrapposizione, un conflitto.
Quand’ero studente per me ogni prova di verifica era un assedio e il professore era l’assediante.
L’unica forma di valutazione che conoscevo era il voto.
Quando ho cominciato ad insegnare ho scoperto che esisteva tra gli studiosi della valutazione una distinzione tra la valutazione tradizionale, l’unica che conoscevo sino a quel momento, chiamata valutazione sommativa e una forma di valutazione definita valutazione formativa.
La valutazione sommativa, cioè il voto, valuta il risultato dell’apprendimento.
Tutti conosciamo i guai di questa forma di valutazione: l’estrema aleatorietà e soggettività, i criteri del voto cambiano da docente a docente o da sezione a sezione; tra l’altro ha effetti negativi anche sull’educazione alla cittadinanza perché il primo rapporto che i giovani cittadini hanno con l’amministrazione della giustizia da parte dello Stato è questa confusa distribuzione di premi e punizioni.
Per ridurre la soggettività, negli ultimi decenni si è andati in cerca dell’oggettività; abbiamo assistito alla proliferazione di griglie valutative, ricche di indicatori, descrittori ecc.; tentativo nobile ma a volte si ha l’impressione che la toppa sia peggio del buco.
Infine, ritornando all’educazione alla cittadinanza, il voto addestra ad essere individui in competizione.
E questo, da un punto di vista educativo, non è un gran che.
La valutazione formativa prende le mosse da una normale verifica, ma non si conclude con l’assegnazione di un voto ma con una riflessione del docente e dell’allievo/a su quanto fatto dall’allievo/a in quella prova: su cosa quella prova ci dice di ciò che è stato appreso e di ciò che è stato
insegnato. La valutazione formativa permette al ragazzo/a, sotto la guida del docente, di mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza dello studio che sta svolgendo; ha come importante obiettivo lo sviluppo dell’autovalutazione dell’allievo/a. Infine il docente gli/le suggerisce le strategie da adottare per migliorare.
E’, come si dice, una valutazione per l’apprendimento e non dell’apprendimento, quale è la valutazione sommativa. E’ uno strumento, non è un fine.
Ma la valutazione formativa non è solo “formativa” rispetto all’apprendimento dell’allievo/a ma anche rispetto all’insegnamento del docente: consente infatti al docente di capire quali aspetti del suo lavoro con la classe stanno avendo successo e quali richiedono una revisione; è finalizzata a cambiare la pratica didattica.
Non c’è bisogno di sottolineare che quindi la valutazione formativa è la valutazione davvero “educativa”, quella valutazione che può produrre un clima di fiducia e collaborazione.
La strada da seguire è quella, aperta dalla recente normativa della primaria, di sostituire in tutti i gradi scolastici il voto con attività di valutazione formativa almeno durante il corso dell’anno scolastico, in iitinere.
Se si vuole creare un clima davvero educativo e “fiducioso” si può ancora raccogliere un’indicazione del maestro Franco Lorenzoni quando propone che alcune esperienze fatte in classe siano messe al riparo da quella che chiama “l’epidemia valutativa”.
Ci sono alcune attività che vanno protette, perché bambini e ragazzi si possano sentire liberi di essere come sono, senza essere costretti a confrontarsi con un modello prestabilito che misura le loro prestazioni. Quando ciascuno racconta qualcosa di sé in cerchio, dalla scuola dell’infanzia in su, fino all’adolescenza, sappiamo bene che il requisito indispensabile perché possa aprirsi agli altri ed esprimersi liberamente sta nella creazione di un luogo e di un tempo in cui non ci deve essere alcun giudizio da parte dell’insegnante.
[…]
Costruire giorno dopo giorno la possibilità di elaborare ed esprimere il proprio pensiero sulle cose più diverse, nel tempo riesce a dare a tutti la consapevolezza della dignità del proprio pensare e ragionare, indispensabile per far nascere ed accrescere il desiderio di conoscenza.
Solo in un clima di fiducia l’allievo/a può raggiungere la “consapevolezza della dignità del proprio pensare”, può sentire che ciò che pensa “ha valore”, è “degno”. E questa è la condizione per conseguire il vero fine della scuola, l’accrescimento del “desiderio di conoscenza”.
1 G.Armellini, A chi e a che serve la valutazione?, in “Gli Asini” 18/2013, p.35.
2 F.Lorenzoni-R.Passoni, Pratiche sensate di resistenza, in “Gli Asini” 18/2013, p.101.
“La scuola, comunità educante. Parliamone” – Barbara Bertola
Da quando l’espressione Comunità educante è entrata, come premessa assiologica, nel Contratto Nazionale della Scuola (CCNL art.24), tutti la utilizzano con la presunzione di averne compreso il corretto significato; tutti, a seconda del ruolo ricoperto all’interno della comunità stessa dando per scontato di esserne il fulcro; tutti, auspicando un’autoguarigione della scuola per il solo fatto di averla pronunciata. Addirittura durante la contrattazione sindacale viene evocata da chi, sentendosi da sempre escluso, rivendica in suo nome un riconoscimento economico della propria categoria; nel mondo esterno invece viene promossa da chi pensa di esserne coinvolto come guida (famiglia, associazioni professionali, imprese); e, ancora, da chi facendo leva sul senso di responsabilità altrui spera di potersi sottrarre dalle proprie (il mondo della politica).
Nonostante il fastidio dichiaratamente ideologico, chi scrive si ritrova a voler difendere– dirà poi perché – una definizione che non condivide ma che nello stesso tempo vede come interessante spunto di riflessione. Urge un chiarimento preliminare: la premessa è ontologica o deontologica? Nel primo caso il termine comunità, inteso come insieme di persone unite da un profondo vincolo di appartenenza, fiducia e dedizione reciproca, suggerisce una facile obiezione: siamo certi che, nella società contemporanea aperta, dinamica, in veloce movimento, vogliamo che la scuola sia una “comunità di affetti”? Siamo altresì certi che solo facendo leva su una sorta di buonismo universalistico tale comunità possa diventare educante, includente, dialogante, professionalizzante e pacificante? Chi scrive nutre diffidenza perché, prossima alla pensione, ha una memoria politica delle riforme scolastiche e ben ricorda che, negli anni settanta del Novecento, l’espressione comunità educante veniva brandita da una fetta del mondo cattolico in contrapposizione ad un’altra fetta di mondo che si ispirava ad ideali, se non di sinistra, dichiaratamente laici e progressisti. A dir il vero oggi non avvertiamo nella espressione sfumature integraliste che al tempo c’erano, ma temiamo che si possano riaccendere aspetti divisivi che pensavamo non solo dimenticati ma decisamente superati.
Sempre dal punto di vista ontologico: si pensa veramente che, non essendo riusciti attraverso riforme successive a trasformare la scuola in comunità, oggi per il solo fatto di asserirlo la comunità educante esista? E se sì, quale discussione c’è stata attorno ai valori, scopi, fini e obiettivi (non sinonimi) da perseguire?
Nel secondo caso invece, nel caso in cui l’asserzione sia deontologica, l’attenzione si sposta non tanto sul sostantivo, comunità, ma sull’aggettivo educante. In questa circostanza inutile sottolineare che sarebbe meglio dire educativa, a voler sottolineare l’intenzione di un lavoro progettuale per sua natura “inattuale” e mai concluso, che necessita di impegno, sostegno e riconoscimento.
Abbandonata dunque l’idea della comunità, come insieme di persone motivate e di buone intenzioni, e corretto l’aggettivo, cosa rimane? La riaffermazione dei contenuti, giustissimi ma non inediti:
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
Nulla di nuovo dunque se non la novità di trovarsi all’interno del contratto nazionale di lavoro. Pur con qualche perplessità sulla collocazione, riteniamo che i contenuti e il richiamo all’assunzione di responsabilità di ognuno siano (ancora) da difendere. In realtà la scuola sta già lavorando come sistema educativo integrato, all’interno del quale l’organizzazione dell’istruzione e la progettazione dell’educazione avviene con il richiamo alle responsabilità di ognuno nel compiere il proprio incarico (munus) insieme con (cum) altri, ovvero le componenti interne (docenti, il personale Ata, studenti e famiglie) e la rete dei servizi del territorio (biblioteche, servizi sociali, imprese, servizio sanitario), con un occhio a ciò che avviene fuori dal territorio nazionale. Nella scuola come sistema integrato le varie componenti che la costituiscono vengono considerate nella loro interrelazione, secondo le modalità interpretative suggerite dalla teoria dei sistemi, per cui ciascun elemento dipende e influisce sull’intero sistema in cui è iscritto. Questo sistema è la scuola, non oggi ma negli ultimi cinquanta anni. L’urgenza dunque non sta in nuove dichiarazioni di intento ma nella necessità che le varie componenti diventino consapevoli di far parte, che lo vogliano o no, di un tutto. Per evitare che altri lo facciano per lei, la scuola oggi non può dunque esimersi dal ripensare se stessa, al suo essere ISTITUZIONE – ancor prima che comunità – che gode di AUTOMIA che le consente di elaborare la
propria offerta formativa in funzione delle caratteristiche socio-culturali e produttive del territorio, e di essere SISTEMA articolato e complesso, all’interno di sistemi articolati e complessi.
La crisi attuale della Scuola nasce proprio dal divario tra ciò che essa è o potrebbe essere e l’insieme delle attese sociali da cui è investita. Da più parti le vengono suggeriti gli scopi da perseguire: le associazioni professionali ed economiche le chiedono maggiore specializzazione in funzione delle richieste poste dallo sviluppo tecnologico; i genitori le chiedono un grosso impegno educativo a compensazione di quanto essi non sono più in grado di fare; gli alunni a loro volta chiedono di poter dare significato a quanto imparano a scuola e invocano maggior attenzione per i loro problemi, senza saperli esplicitare. Per poter soddisfare questa richiesta di minor scollamento tra scuola e realtà, è bene che sia Scuola a dare l’avvio ad una seria riflessione sui propri fondamenti e sulle proprie condizioni di possibilità, escludendo pratiche educative fondate semplicemente sul disarmante buon senso, sul senso comune che dà voce a tutti, su teorie date per scontate e dunque dogmatiche. La Scuola, se vuole risolvere le contraddizioni che oggi la dilaniano e non vuole perdere di credibilità, deve non solo occuparsi di risolvere – con efficacia ed efficienza – problemi pratici e burocratici che le tolgono energia, ma deve assumersi la responsabilità di chiarire i fondamenti teorici su cui si basa e da cui discendono i fini (che riguardano la formazione e lo sviluppo della personalità del soggetto), gli scopi (in merito all’arricchimento derivante dalle conoscenze disciplinari) e gli obiettivi (prevalentemente didattici). E’ dagli anni Settanta, con successo alterno, che si cerca di andare in questa direzione: i Decreti Delegati del 1974, la successiva Legge n.517/1977 e in seguito le cosiddette sperimentazioni “assistite” fino al dibattito attuale hanno contribuito ad estendere la partecipazione alla gestione scolastica e alla produzione di “rapporti” (Coleman, Faure, Delors, Cresson per citarne alcuni) a livello internazionale su cui orientare le riforme. Al proprio interno invece la Scuola poco è riuscita a fare: ancora troppo legata alla parcellizzazione nozionistica del sapere non è riuscita a fare sua la prospettiva sistemica della complessità, per natura problematica, discontinua e non prevedibile ma l’unica in grado di dare senso all’operato degli attori coinvolti dentro e fuori la scuola. Se la scuola riuscisse a prendersi l’impegno di operare secondo le indicazioni del pensiero sistemico e di autori come Morin, Bertin e Massa riuscirebbe anche a recuperar il senso positivo di comunità come ecclesia, nell’accezione greca e non latina. Ma di questo parleremo un’altra volta.